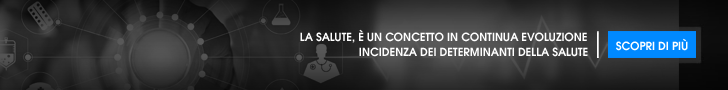Calo demografico, fuga dei giovani, mancanza di prospettive: quale futuro?
Pillole di conoscenza

|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Nel 2024 l’Italia continua a fare i conti con un calo demografico costante: meno nascite, più emigrazioni e un invecchiamento sempre più marcato della popolazione con la speranza di vita che torna a crescere.
Il quadro demografico italiano tracciato dall’Istat nel Report Indicatori Demografici 2024 conferma un’Italia in profonda trasformazione. Tanti i segnali di allarme: una natalità ai minimi, una popolazione sempre più anziana, un tessuto familiare che cambia e una mobilità che accentua le disuguaglianze territoriali.
Nel 2024 la fecondità ha toccato il minimo storico: solo 1,18 figli per donna, superando al ribasso il precedente record negativo del 1995 (1,19). I nuovi nati sono stati solo 370mila, 10mila in meno rispetto al 2023 e ben 156mila in meno rispetto al 1995. A pesare è anche l’età media delle madri, salita a 32,6 anni, segno di una maternità sempre più posticipata. Popolazione in calo, ma con divari territoriali. La popolazione residente al 31 dicembre 2024 è di 58 milioni e 934mila unità, in calo di 37mila (-0,6 per mille). Tuttavia, il decremento non è omogeneo: mentre il Nord cresce (+1,6 per mille), il Mezzogiorno continua a perdere abitanti (-3,8 per mille), con punte critiche in Basilicata (-6,3) e Sardegna (-5,8).
Torna a crescere la speranza di vita, che raggiunge gli 83,4 anni, con un guadagno di 5 mesi rispetto al 2023. Gli uomini possono ora aspettarsi 81,4 anni di vita, le donne 85,5. Si tratta di valori superiori anche al periodo pre-pandemico, confermando il superamento dell’emergenza sanitaria.
Nel Nord la speranza di vita alla nascita è di 82,1 anni per gli uomini e di 86,0 per le donne; i primi recuperano cinque mesi rispetto all’anno precedente, le donne invece quasi quattro mesi. Il Trentino-Alto Adige si conferma ancora come la regione in Italia con la speranza di vita più alta sia tra gli uomini (82,7) sia tra le donne (86,7). Nel Centro la speranza di vita alla nascita è 81,8 anni per gli uomini e 85,7 anni per le donne, con un incremento di quasi quattro mesi rispetto al 2023 per entrambi i sessi. In questa ripartizione geografica le Marche sono la regione dove si vive più a lungo, con un valore della speranza di vita alla nascita di 82,2 anni per gli uomini e 86,2 per le donne. Nel Mezzogiorno si registrano valori più bassi della speranza di vita alla nascita: 80,3 anni per gli uomini e 84,6 anni per le donne. L’Abruzzo è la regione che consegue guadagni di sopravvivenza maggiori tra gli uomini, oltre 8 mesi in più sul 2023. Significativi, sempre nel Mezzogiorno, sono i guadagni ottenuti tra le donne in Sicilia, Basilicata e Calabria, ben 6 mesi in più. La Campania, nonostante un considerevole recupero, rimane la regione con la speranza di vita più bassa tanto tra gli uomini (79,7) quanto tra le donne (83,8).
Si registra anche un invecchiamento marcato della popolazione con famiglie sempre più piccole e sole. Famiglie sempre più piccole e sole. Il numero medio di componenti per famiglia è sceso a 2,2, rispetto ai 2,6 di venti anni fa. Oggi oltre un terzo delle famiglie italiane (36,2%) è costituito da una sola persona. Le coppie con figli rappresentano meno del 30%, mentre aumentano le famiglie monogenitoriali (10,8%) e quelle senza figli (20,2%). Un’Italia che invecchia: 1 su 4 ha più di 65 anni. L’età media della popolazione ha raggiunto i 46,8 anni. I residenti over 65 sono 14,6 milioni (24,7% della popolazione), in crescita. Particolarmente significativa la crescita degli ultra85enni (2,4 milioni) e degli ultracentenari (oltre 23.500, l’83% donne). Solo l’11,9% della popolazione ha meno di 14 anni. Un lento ma costante declino che incide sul tessuto sociale ed economico del Paese.
Nel 2024 aumentano di oltre il 20% le emigrazioni per l’estero, che passano da 158mila del 2023 a poco meno di 191mila, facendo registrare così il valore più elevato finora osservato negli anni Duemila. L’aumento è dovuto esclusivamente all’impennata di espatri di cittadini italiani (156mila, +36,5% rispetto al 2023) che si dirigono prevalentemente in Germania (12,8%), Spagna (12,1%) e Regno Unito (11,9%), mentre circa il 23% delle emigrazioni dei cittadini stranieri è riconducibile al rientro in patria dei cittadini romeni. Al tempo stesso, sono aumentate le acquisizioni di cittadinanza italiana: 217mila nel 2024, nuovo record assoluto. In testa gli albanesi (31mila), seguiti da marocchini e romeni.
Nel 2024 i trasferimenti di residenza tra Comuni italiani si attestano a 1 milione e 413mila, segnando una diminuzione dell’1,4% rispetto al 2023 (-20mila trasferimenti). La contrazione è dovuta alla riduzione della mobilità interna dei cittadini italiani, che registra un calo del 3,4%. Al contrario, tra i cittadini stranieri la mobilità interna è in un aumento del 7,8%. Anche nel 2024 il Mezzogiorno conferma un saldo migratorio interno negativo (-52mila, -2,6 per mille abitanti). Sono oltre 401mila le partenze da un Comune meridionale a un altro Comune italiano (sia all’interno del Mezzogiorno sia verso altre aree del Paese), mentre i flussi in entrata verso Comuni del Mezzogiorno si fermano a circa 349mila. La perdita di popolazione nel Mezzogiorno dovuta agli spostamenti tra i Comuni colpisce tutte le regioni dell’area, con intensità più marcata in Basilicata e Calabria dove si osservano i tassi migratori negativi più alti: rispettivamente -5,0 per mille e -4,6 per mille. Anche il Molise (-3,8 per mille) e la Campania (-3,3 per mille) mostrano un tasso migratorio negativo significativo, sebbene meno accentuato. Le regioni del Nord si confermano le più attrattive: nel 2024 i trasferimenti verso i Comuni del Nord (provenienti da qualsiasi area, incluso lo stesso Nord) sono stati 815mila, a fronte di 768mila spostamenti in uscita, flussi che generano un saldo migratorio positivo di 47mila abitanti, pari a +1,7 per mille. L’Emilia-Romagna è la regione con il tasso migratorio più alto (+2,7 per mille), seguita dal Piemonte (+2,2 per mille) e dalla Valle d’Aosta (+1,9 per mille). Anche il Centro presenta un saldo migratorio positivo, seppur più contenuto, con un tasso pari a +0,4 per mille.